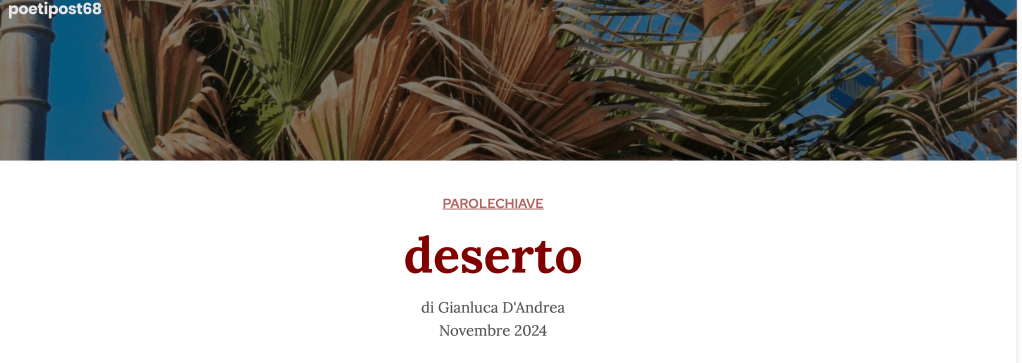
Il deserto, l’abbandono (dal verbo latino deserere, che priva di connessione e svuota), è la terra piatta che si apre a vista d’occhio, che non occulta i suoi segreti ma li espone nella loro crudezza a chi deve attraversarlo, è l’assoluto dell’inizio ed è qui, nel presente in cui annotiamo il nostro bisogno di relazione.
Dietro l’angolo, attraversando la soglia che ci muove al rischio, in cammino verso l’alea che ci compone tra presenza e solitudine, il deserto si presenta ed è prima del segno, è desiderio e oblio nella mera percezione del quotidiano che passando si astrae (si fissa? ma poi per quanto?) nella parola.
Il deserto è la parola spaesata che ri-comincia per scoprire nuovamente un tragitto, per esserne scelti:
A Hiroshima
arduo esercizio zen
non pensarci
30 giugno 2002
Durs Grünbein, da Lob das Taifuns (Insel 2008, trad. a cura di Valentina Di Rosa, in Le parole non dormono, Crocetti 2023)
Sfogliando il libro di Grünbein, mi fermo su questo testo, un haiku su Hiroshima, perché leggendolo sento un disagio. Si parla del grande rimosso della bomba giocando con le pratiche buddiste di meditazione che tendono al satori, all’oltre che annienta i confini tra io e mondo, un oltre che non è illuminazione improvvisa ma un’esperienza che per un attimo conclude un percorso di forti privazioni, di sacrifici per proiettarsi intimamente dentro il mondo, compartecipando. Al contrario, Hiroshima è l’acme di un percorso di conoscenza, attraverso un metodo che sperimenta il mondo come se fosse una cavia e che conduce, nel caso specifico, al parossismo della detonazione. Nel suo percorso progressivo e “ascendente” l’occidente giunge a una meta immane, che sconvolge la relazione tra io e contesto, un punto di non ritorno della relazione che non può trovare nuovi equilibri a meno che non si ricominci dalla rinuncia alla presa sul mondo. Questo, però, ha bisogno di una consapevolezza anche più estrema, una rinuncia al potere anche deterrente simboleggiato dall’ordigno e, quindi, al potere tout court.
Ma come non pensarci, come rimuovere davvero la folgorazione di un potere che ci ha colpiti talmente in profondità da rendere l’estinzione più vicina di un tocco di dita e che ci costringe a un altro travisato satori, quello della fuga da o in noi stessi, lontani dal contatto?
Da Hiroshima in poi, nella finzione del non pensarci, cadiamo costantemente nella pura superficie della rappresentazione, ed è evidentemente una caduta paradossale, anche questa inaudita: verso una partecipazione attiva che collima con uno stordimento spettacolare e collettivo.
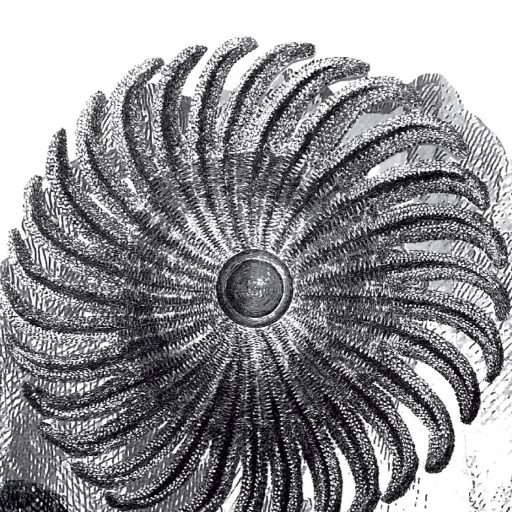
Lascia un commento